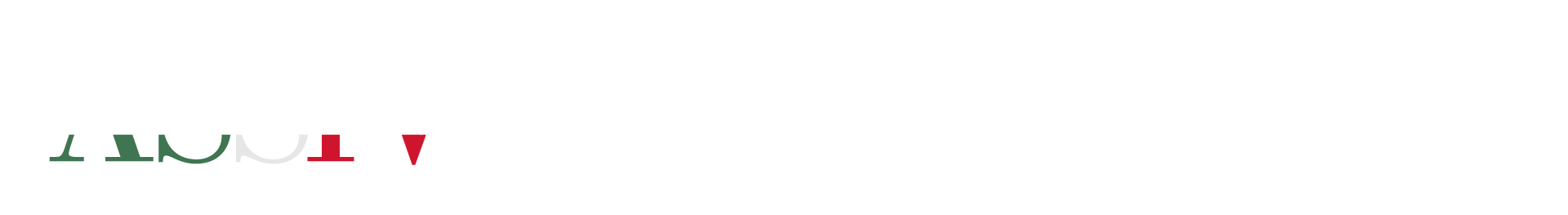Il settimanale Panorama (edizione del 1° ottobre 2025) dedica un ampio approfondimento alla situazione del comparto della sicurezza privata in Italia. L’articolo, “Agenti di vigilanza cercansi”, mette in evidenza un fenomeno ormai evidente a tutti gli operatori: la crescente difficoltà delle imprese a reperire personale qualificato, in un contesto in cui la domanda di servizi di sicurezza è in costante aumento.
Tra le voci citate, anche quella di Angelo Merlo (Presidente dell’Istituto di Vigilanza Notturna Gallarate), storico associato ASSIV, che da tempo richiama l’attenzione sulle difficoltà del comparto nel trovare risorse adeguatamente formate e motivate. La sua testimonianza rappresenta un segnale importante della realtà quotidiana vissuta dalle imprese di vigilanza su tutto il territorio nazionale.
Come ricordato dalla Presidente di ASSIV, Maria Cristina Urbano, la carenza di personale si innesta su una serie di criticità strutturali che gravano sulle imprese:
- un quadro normativo complesso e spesso rigido, che non favorisce l’innovazione e l’efficienza organizzativa;
- la persistenza, ancora oggi, di stazioni appaltanti che bandiscono gare al massimo ribasso, penalizzando la qualità del servizio e la sostenibilità delle imprese;
- la scarsa attrattività della professione, spesso percepita come poco riconosciuta a livello sociale, nonostante l’alto valore pubblico della funzione svolta.
In questo scenario, Maria Cristina Urbano sottolinea la necessità di rafforzare il dialogo con le istituzioni e di promuovere interventi mirati che possano sostenere il settore, valorizzando la professionalità degli operatori e riconoscendo il ruolo strategico delle guardie particolari giurate nella sicurezza complessiva del Paese.
ASSIV accoglie con favore che una testata nazionale come Panorama abbia dedicato spazio a questa tematica. La sicurezza privata non è soltanto un comparto occupazionale, ma una leva strategica per la sicurezza complessiva del Paese, a supporto delle istituzioni e a tutela dei cittadini.
ASSIV continuerà a farsi portavoce delle istanze delle imprese e degli operatori, promuovendo un riconoscimento pieno del ruolo delle guardie particolari giurate e di tutto il comparto della vigilanza privata.
Fonte: Panorama, 1 ottobre 2025, “Agenti di vigilanza cercansi”